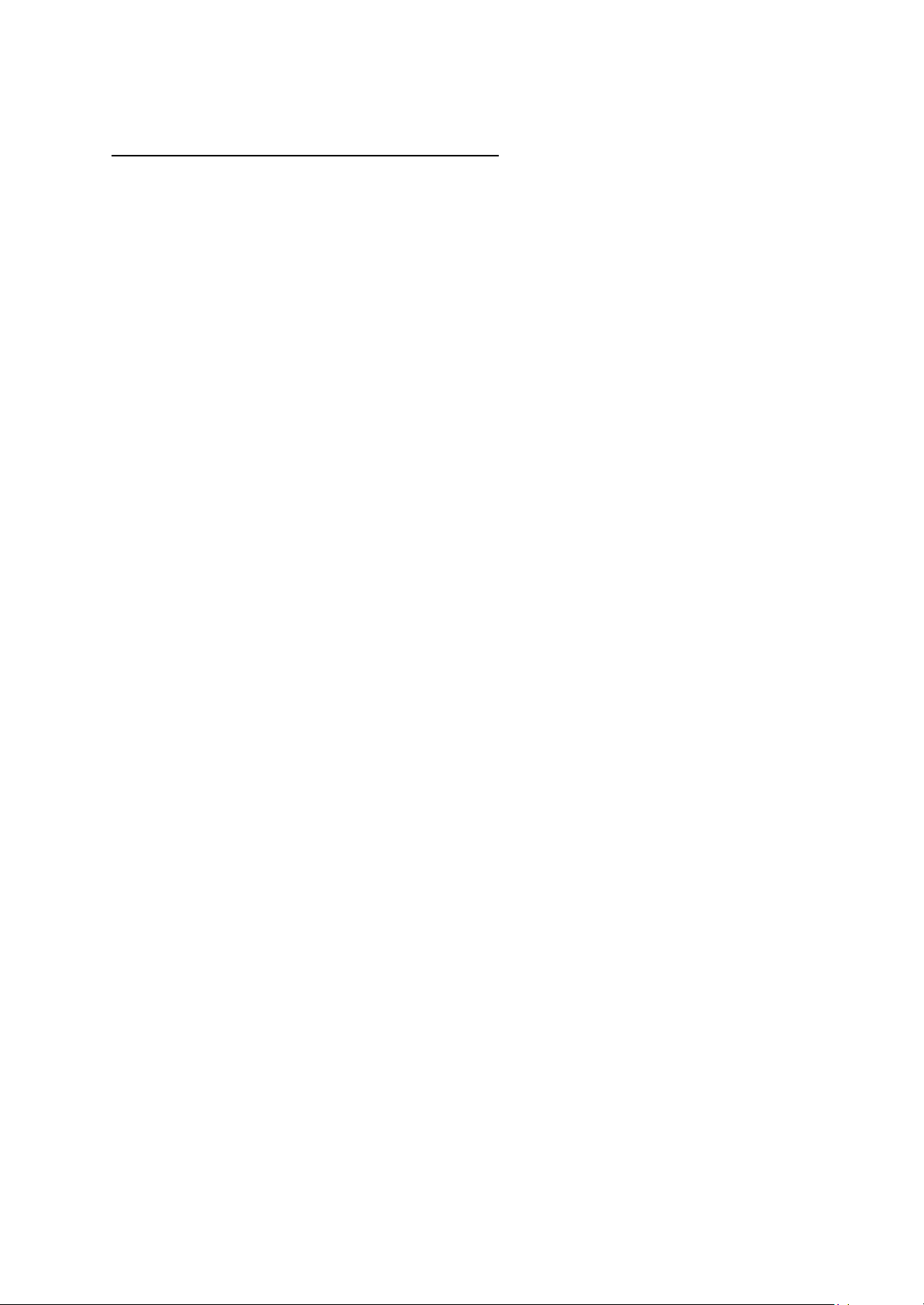








Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
I migliori documenti in vendita da studenti che hanno completato gli studi
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari

Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Community
Chiedi aiuto alla community e sciogli i tuoi dubbi legati allo studio
Scopri le migliori università del tuo paese secondo gli utenti Docsity
Guide Gratuite
Scarica gratuitamente le nostre guide sulle tecniche di studio, metodi per gestire l'ansia, dritte per la tesi realizzati da tutor Docsity
riassunto capitoli quattro e cinque del libro di Luca Serianni
Tipologia: Sintesi del corso
1 / 11

Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!
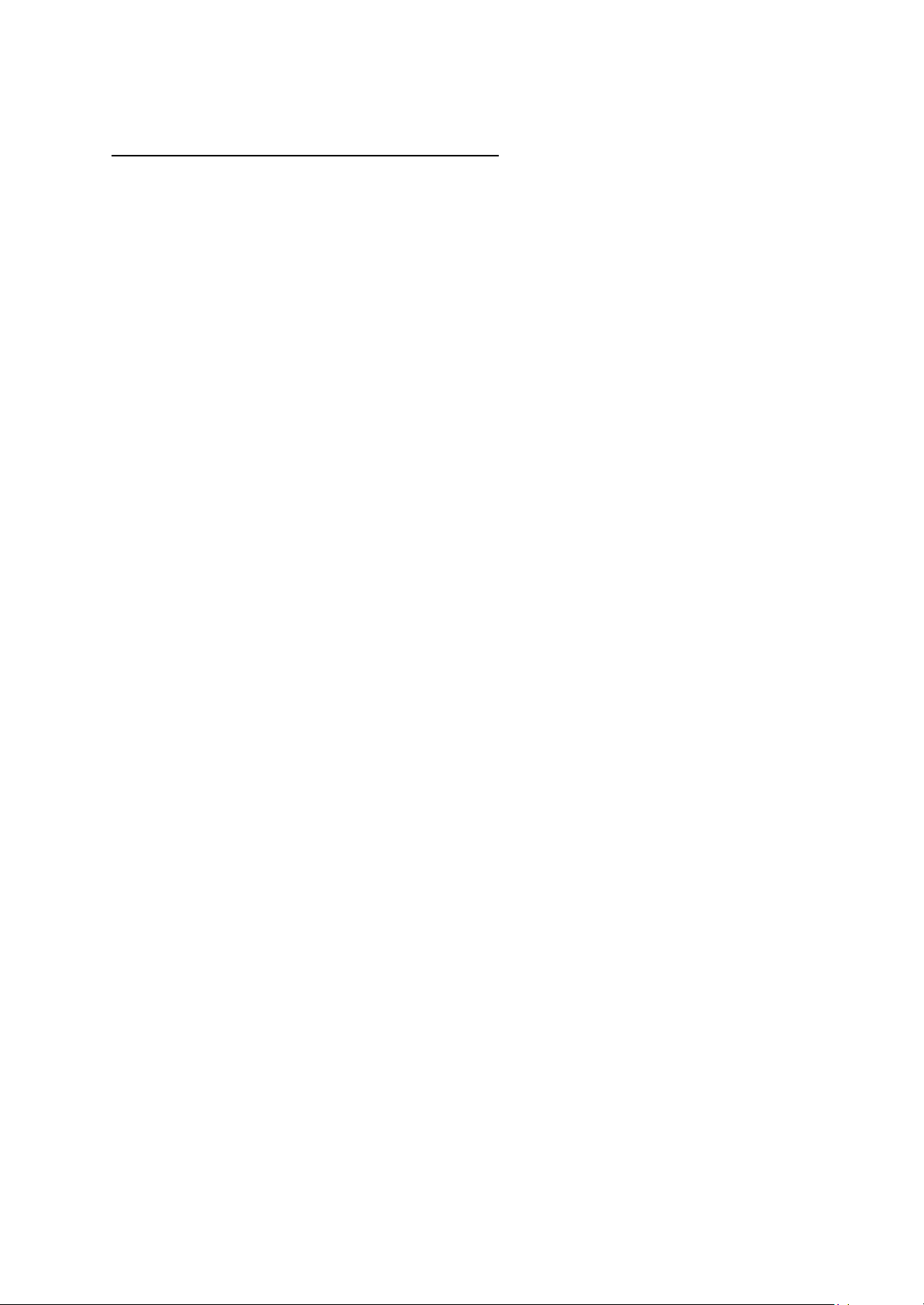






Norma dei grammatici e norma degli utenti (cap. 4) Non è banale parlare di norma. La norma è una legge, dà delle indicazioni e viene riconosciuta, può diventare un dovere poiché ci sono delle conseguenze se non viene rispettata. Innanzitutto quindi dev’essere condivisa , posso parlare di legge o norma solo se parlo di una collettività , non se parlo dell’individuo. E’ un dovere, quindi entra in gioco il concetto di potere: serve un potere che porta delle conseguenze negative se qualcuno non fa il suo dovere. Alla luce di ciò possiamo intendere cos’è la norma: la norma va messa in dialogo con il sistema, c’è questo binomio. Questo viene formulato in un importante saggio di un linguista romeno, Coseriu , 1952, chiamato “ Sistema, norma e Parole ”. Coseriu definisce il sistema come: l’insieme delle possibilità astratte garantite dai meccanismi formativi della lingua, anche quelle che esistono solo virtualmente. Tutto ciò che posso produrre con le regole dell’italiano, al di là del fatto che sia nei vocabolari o no, riguarda il sistema. Quindi in italiano ci sono alcune regole, non posso dire “io prendere il treno” perché le regole di base dell’italiano vogliono che il verbo sia coniugato e accordato con il soggetto. Questa sarebbe una creazione fuori dalle regole. Però il bambino che qualche tempo fa si è inventato “petaloso” ha usato queste regole creando una parola che non è nei vocaboli ma che si può usare, è una creazione virtuale dell’italiano poichè non è nel vocabolario e non si è diffusa però rientra nel sistema: con il suffisso -oso infatti posso creare aggettivi a partire da nomi, se da “onda” ottengo “ondoso”, lo stesso posso fare con “petalo”, questo è un esempio di espressione che fa parte del sistema. Oppure se uso il suffisso -icch da alcuni verbi posso ottenere un verbo alterato , “giochiccio”, “mangicchio”. Il sistema quindi racchiude tutte le possibilità astratte garantite dai meccanismi formativi, al di là che abbiano senso o no, al di là che abbiano successo o no. Ancora meglio, è l'insieme delle possibilità astratte garantite dai meccanismi formativi della lingua, alcune delle quali non sono attualizzate ma esistono solo virtualmente. La norma invece è l’ attualizzazione del sistema, che si realizza nel corso della storia (la norma si evolve nel tempo) e viene considerata accettabile dalla comunità dei parlanti , viene considerata accettabile dalla comunità dei parlanti (concetto di collettività ). Quindi all’interno di tutto ciò che posso fare con le potenzialità dell’italiano, ci sono alcune realizzazioni che dalla collettività sono ritenute accettabili e altre no. Serianni cita un esempio fatto da Coseriu, per rappresentare la differenza tra “norma” e “sistema”: l’espresso di Parigi delle 8:20. In esso, come in qualsiasi altro treno, si possono individuare alcuni elementi di sistema: l’orario di partenza e di arrivo, ad esempio, o il numero delle fermate sono tratti costitutivi senza i quali non esisterebbe quel certo treno delle 8.20. Altri elementi rientrano invece nella “norma” (cioè quello che può cambiare): la disposizione dei vagoni, il loro numero, il loro colore e così via. Sono elementi, questi ultimi, che ci aspettiamo di veder rispettati se siamo utenti abituali di quella linea, ma la cui mancanza non implica la non-esistenza del treno in questione e le ferrovie non si sentirebbero in obbligo di avvisare i viaggiatori dei mutamenti. *
Però continuo a chiamarlo “il treno delle 8:20”, mantiene la stessa categoria, nel momento in cui comincia a partire dalle 8:25, cambia l’orario di arrivo o altro, per me non è più il “treno delle 8:20”. Sono cambiati talmente tanti elementi da non poter parlare più di sistema, lo stesso vale per la linguistica. Ci sono degli elementi di base, che fanno sì che si parli di “sistema dell’italiano” (ad es. le carrozze, l’orario di partenza…), elementi che riguardano la “norma” sono le dislocazioni, ogni tanto la punteggiatura ecc… |Serianni aggiunge un elemento importante al binomio norma-sistema, cioè l’importanza della sanzione sociale, il giudizio linguistico dei parlanti, per questo Serianni sviluppa un paragone tra lingua e diritto. Così come la nostra legge stabilisce che ci sono atti che secondo il comune sentimento offendono il pudore, anche a livello linguistico parliamo di pudore linguistico, alcuni errori lo danneggiano altri no. In passato sono stati ritenuti scandalosi dei francesismi adattati, come “doppiaggio” piuttosto si usava “doppiamento” per evitare il suffisso -aggio, “sabotaggio”. Il termine invece parole rimanda a Saussure, linguista francese, una coppia importante, oltre alla differenza tra significante e significato, é quella di langue e parole. La langue é collegata alla collettività, è quell’espressione linguistica riferita alla collettività, è condivisa. Io mi esprimo in modo che sia condivisa dagli altri la mia modalità. Espressione linguistica in un contesto sociale. La parole (individualità) invece è ciò che rimanda alla mia individuale creatività linguistica. Magari sono una persona che dice tante volte “cioè”, che ripete lo stesso connettivo, che usa aggettivi arcaici ecc… È lo stile di espressione personale, sia scritta che parlata. Questo é un concetto importante, che Coseriu collega a “sistema” e “norma”, nel titolo del suo saggio e la riprende appunto da Saussure la “parole”. Così come il cittadino sa quali sono i comportamenti da evitare, anche se non ha studiato diritto, e lo sa per esperienza. Questo avviene anche nella linguistica: norma implicita, cioè noi introiettiamo la norma implicita anche se nessuno ci ha detto “guarda che se sbagli a con l’h non va bene”. Non ci sono assoluti però, infatti nel libro si parla di zona grigia tra giusto e sbagliato, nell’italiano abbiamo un’ampia zona grigia così. Serianni dice che è molto più estesa nell’italiano rispetto ad altre lingue europee, per la sua storia, perché è stata scritta per secoli, non é stata unitaria. A proposito di Zona grigia, Serianni cita un’opera di Valeria Della Valle e Giuseppe Patota “Il salvalingua”. Questi libri influenzano la norma. Nel salvalingua, c’è una visione della lingua che non è paragonabile al tribunale, in cui c’è il “giusto” e “sbagliato”, ma è una piazza in cui troviamo persone vestite in maniera diversa a seconda delle attività che fanno, una piazza in cui passeggiano persone vestite in modo diverso perché svolgono differenti attività: come vicino all’inappuntabile completo del funzionario di banca si osservano la maglia e i calzoncini del suo collega in ferie che sta facendo jogging, così molte alternative linguistiche vengono opportunamente dislocate sull’asse della variabilità diafasica. Linguisticamente dobbiamo avere questo occhio anche noi, non c’è giusto o sbagliato ma un vestito più adatto ad un’occasione/circostanza o ad un’altra. Vediamo un’apertura nella trattazione di alcuni aspetti all’interno de “Il salvalingua”, ci sono alcune scelte che vengono viste come equivalenti.|
lasciato senza l'appoggio di una funzione sintattica congruente; rispetto ai successivi, rimane “sospeso” e nello stesso tempo viene messo in evidenza». In una lettera al «Corr. Sera» del 28.6.2005, l’onorevole Gustavo Selva incappa in un incidente del genere:
Ma la conversazione che Sandro Bondi ha avuto per il «Corriere della Sera» con Massimo Franco, se non è da considerarsi un puro esercizio di ipotesi politiche, essendo Bondi la “voce” di Berlusconi ci sarebbe da pensare a qualcosa di più di un breve saggio storico-politico.
Tutto sarebbe andato a posto se il tema la conversazione fosse stato incluso entro la proposizione condizionale (= «Ma se la conversazione non è da considerarsi...»; visto che ci siamo, dopo Berlusconi occorreva una virgola), oppure se il contesto fosse stato colloquiale, vicino alle modalità del parlato (sono ben noti gli anacoluti dei Promessi sposi; ecco invece un efficace esempio di Ernesto Galli della Loggia [«Corr. Sera», 5.8.2005]: «Di tutto ciò, però, la destra italiana si direbbe che non gliene potrebbe importare di meno»; alternativa grammaticalmente corretta, ma scialba come impatto pragmatico: «Di tutto ciò, però, alla destra italiana si direbbe che non potrebbe importare di meno»). E nessuno si sarebbe accorto di nulla – lo ribadiamo – se le parole di Selva fossero state pronunciate, magari in Parlamento, ma non scritte. Insomma: quali sono i parametri per definire e per valutare la norma linguistica? Come Coseriu col suo treno, possiamo ricorrere anche noi a un paragone: quello tra lingua e diritto. Un articolo del codice penale italiano, il n. 529, definisce osceni «gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore». Il parallelo tra due istituzioni fortemente sociali come la lingua e il diritto è stato proposto molte volte; e anche in questo caso è possibile immaginare un parallelo tra pudore morale e “pudore linguistico”, ossia percezione della correttezza linguistica da parte dei parlanti e conseguente reattività nei casi di violazione di norme comunemente condivise. Com’è intuibile, il concetto di pudore è andato e va soggetto a interpretazioni varie presso i tecnici del diritto: una situazione che poteva consigliarne l’applicazione in un ambiente rurale della Sicilia negli anni Cinquanta non potrebbe evidentemente valere nella Milano del 2006. Allo stesso modo un repertorio grammaticale di cinquant’anni fa poteva deplorare innocui francesismi oggi stabilmente radicati nel lessico come doppiaggio («Dobbiamo dire doppiatura o doppiato») o sabotaggio («Diremo: atti di vandalismo, vandalismo, guasto (doloso), devastazione, distruzione e sim.») ovvero diventati marginali se non obsoleti come gagà («Comune. da noi la si usa per bellimbusto, elegantone, damerino, zerbinotto e sim.») o poseur. Continuando nel nostro parallelo, osserveremo che alla dottrina, ossia all’elaborazione scientifica del diritto, possono corrispondere non tanto gli studi linguistici veri e propri, che non hanno intenti normativi, quanto la serie di testi (grammatiche, repertori, interventi di docenti e di giornalisti) che dibattono temi grammaticali, proponendo e consigliando. Alla giurisprudenza, cioè all’insieme delle sentenze degli organi giurisdizionali, corrispondono le sanzioni irrogate dalla scuola di ogni ordine e grado (anche in un concorso pubblico distante dall'ambito letterario, uno scritto sgrammaticato può essere sanzionato, compromettendo l’esito della prova).
Infine: come l’azione penale può essere promossa dall’iniziativa del singolo cittadino che denunci un reato, così i singoli utenti possono lamentare pubblicamente un cattivo uso linguistico attraverso i mezzi di comunicazione di massa, soprattutto scrivendo ai giornali. Ma l’elemento più interessante che potrebbe emergere da questo confronto è un altro: come il cittadino, anche digiuno di diritto, ha interiorizzato una serie di norme giuridiche, quelle fondamentali, ed è consapevole del confine lecito-illecito, così l’utente di una lingua, anche analfabeta, sa che alcune esecuzioni violerebbero irrimediabilmente lo statuto di quella lingua (non sono ammissibili in italiano * parla a io! né in francese * parle a je! né in tedesco
insieme con, malgrado l’avesse avvisato / malgrado che l’avesse avvisato, tre e mezzo / tre e mezza, senza te / senza di te ) e della sintassi (concordanza a senso, uso dell’ausiliare essere e avere in molti intransitivi). A una certa tradizione puristica, quella delle facezie per rendere accattivante una materia di per sé piuttosto inamena, anche Il salvalingua non è peraltro insensibile: si vedano le battute di spirito (la forma corretta è malediceva , non malediva , benché in un melodramma si canti Quel vecchio maledivami : «ma Rigoletto, con tutto il rispetto, è un buffone di corte, non un premio Nobel per la letteratura»), i calembours ( convenne o convenì ?: «pensiamo che vi convenga usare convenne e che non vi convenga usare convenì. Ne convenite?»), personificazioni giocose (alcune parole che possono scriversi univerbate si rivolgono ai lettori: «Cari lettori, sfortunatamente ci conoscete poco»). Con Fochi, Della Valle e Patota, per riprendere la metafora giuridica dalla quale siamo partiti, abbiamo dato la parola alla dottrina; è necessario ascoltare ora la voce dei denuncianti, che sentiremo singolarmente concorde. Per evitare la casualità di prelievi rapsodici, possiamo fondarci sulle lettere ospitate nel foglio «La Crusca per voi» che l’Accademia della Crusca dedica, come si legge nel frontespizio, «alle scuole e agli amatori della lingua». Il foglio, apparso nell’ottobre 1990 , si pubblica in due numeri annui ed è arrivato nell’ottobre 2004 al n. 29. Una rubrica fissa comprende le domande che i lettori rivolgono alla Crusca e alle quali gli accademici (e negli ultimi anni singoli studiosi che non sono soci dell’Accademia) rispondono offrendo una consulenza che impegna naturalmente solo la loro personale valutazione di singoli problemi. L’ampia copertura (quattordici anni) e il successo di pubblico del foglio, distribuito in circa 12.000-13.000 copie (e quindi verosimilmente in grado di raggiungere varie decine di migliaia di lettori), consentono qualche riflessione non estemporanea sui temi a cui è più sensibile la massa di coloro che si interessano alla lingua (non si tratta solo di insegnanti e di studenti, che pure rappresentano la più gran parte degli scriventi). Ma prima di tutto mi si permetterà – per la lunga esperienza di consulente maturata presso quel periodico – un’osservazione personale: in molti casi, leggendo le lettere originali (che, prima di essere pubblicate, vengono necessariamente riassunte e doverosamente potate di riferimenti al personale vissuto dei mittenti) si resta colpiti dal coinvolgimento emotivo degli scriventi. Ricordo che una lettrice, insegnante in pensione, sollecitò la risposta a un quesito sulla reggenza di un verbo, augurandosi di fare in tempo a leggerla, perché gravemente malata «di un male che non perdona»; e un pensionato accluse alla sua lettera una piccola somma (scusandosi di non poter dare di più), per sostenere un’istituzione che si occupava di «promuovere e difendere l’italiano» secondo lui minacciato da crescenti sgrammaticature. In casi del genere non siamo di fronte a semplici curiosità o magari a scommesse tra amici (si dice o non si dice? sentiamo la Crusca). Tocchiamo con mano il forte investimento simbolico legato alla lingua, anche in minuti aspetti del suo funzionamento, una passione che non viene meno neanche a causa di una grave malattia o delle ristrettezze economiche patite da un anziano.
La reattività del parlante (cap. 5)
A differenza dei suoi lettori, «La Crusca per voi» ci interessa qui non tanto per il merito delle risposte, quanto per la tipologia dei quesiti e per l’immagine della lingua che li ispira. Molto frequente è un atteggiamento iper-razionalistico , fondato sull’idea che la lingua sia un monolite nel quale si possa sempre tracciare il confine giusto-sbagliato sul fondamento di un’astratta immagine della norma, sottratta alla variabilità degli usi concreti. Alcuni muovono dal fastidio per la ridondanza, frutto dell’idea che la lingua possa ridursi alla pura semantica: se una parola non aggiunge nulla al significato della frase, va eliminata. Così, un insegnante toscano lamenta l’uso del possessivo «in contesti in cui non sarebbe affatto necessario» come Trascorrete le vostre vacanze a ... (ma in frasi del genere il possessivo ha lo scopo di agire sul destinatario, lusingandone l’egocentrismo e mettendo in rilievo proprio quelle sue, importantissime, vacanze). Nient’altro che un «errore» – incalza un lettore da Avellino – commette «chi scrive e stampa» piccoli furtarelli (ma la ridondanza – argomenta Nencioni nella sua risposta – è «ammissibile nei discorsi che tendono a convincere, a commuovere, a circuire»). Dalla provincia di Milano una lettrice dice di sentirsi «irritata» quando sente «importanti giornalisti esprimersi con pleonasmi assurdi, quali uscire fuori , come se fosse possibile l’uscire dentro» (e Nencioni, oltre a richiamare la componente emotiva del parlato, ricorda in questo caso l’antico radicamento di fuoriuscire, in cui «la lingua ha fatto, come si dice, una finestra sul tetto sia alle critiche che alle giustificazioni»). Perché si dice panacea di tutti i mali , osserva un lettore romagnolo, se già il sostantivo fa riferimento alla nozione di ‘tutto’? Stretta parente del “pleonasmo” è la “tautologia”: “Tautologico” è, per un lettore bolognese, il verbo suicidarsi , del resto da tempo oggetto di censura da parte dei puristi; e “tautologica”, per un insegnante salernitano, è la locuzione arrivederci a presto , dal momento che la preposizione a è già inclusa nel saluto. Non c’è spazio per la polisemia (in un’espressione come un certo discorso – eccepisce un lettore da Padova – «c’è qualcosa di illogico: dov’è la certezza?»). Né per il potere disambiguante del contesto: per un lettore di Foggia non sono corrette espressioni come la lingua latina e greca , in quanto indurrebbero «nell’equivoco che esista una lingua... bilingue» (e Nencioni, pure ammettendo che un’espressione del genere appare scritta «alla brava, con quel fare compendioso che è proprio del giornalismo», ammonisce a non sottoporre tali sequenze «alla lente logica dell’assurdo perché, nel contesto da cui sono tratte, hanno un significato non ambiguo»). Il significato di una parola è rigido, non ammette estensioni o generalizzazioni: un ragioniere triestino ritiene «più logico» dire, con concordanza a senso, Un gruppo di scolari uscivano dalla scuola , giacché la frase grammaticalmente corretta Un gruppo di scolari usciva dalla scuola attribuirebbe «un’azione (e magari un pensiero o un atto di volontà) a una entità astratta» (e Nencioni replica che, a furia di logicizzare, non si potrebbe più dire L’umanità soffre di troppa violenza , «perché l’umanità, come astrazione, non può soffrire» né L’uomo è un essere ragionevole , «perché l’uomo come generalità concettuale non esiste e perciò può essere ragionevole solo il singolo concreto individuo»: si finirebbe, insomma, col rinunciare «alla ricchezza e alla libertà della nostra lingua, e anche alla spontaneità con cui ne usiamo, riducendoci a uno stato di paralisi espressiva e comunicativa»).
stratificandosi non tanto sulla base della propria esperienza di parlante, quanto sull’immagine di lingua che si è formata soprattutto negli anni di scuola. Di fronte alla richiesta di un sì o di un no, che non è quasi mai possibile soddisfare in termini netti, i linguisti nelle loro risposte tendono a storicizzare il singolo quesito , a inserire un particolare problema nell’alveo di tendenze evolutive di più larga gittata. Forse questo genere di risposta delude l’interlocutore, che si aspetta una diversa militanza in coloro che sono istituzionalmente addetti alla difesa della grammatica. Fatto sta che, di tanto in tanto, gli affezionati lettori della «Crusca per voi» criticano gli usi linguistici degli stessi accademici: e in ciò vedrei meno il gusto di prendere in castagna il professore di turno che la convinzione di considerarsi altrettanto abilitati a interpretare la norma grammaticale. Così un docente bolognese imputa a Nencioni di aver usato una ridondanza scrivendo, in un numero precedente della rivista, resterà anche in futuro (e l’accusato replica, senza perdere il garbo che gli è proprio: «se io dico o scrivo resterà anche in futuro , duplico certamente la nozione di futuro e compio una ridondanza; ma quell’ in futuro intende specificare il futuro verbale, brachilogicamente, come un futuro non di domani o della prossima settimana, ma indefinito nel tempo»). Spesso i “dubbi linguistici” trattati dai repertori grammaticali sono gli stessi sui quali i lettori sollecitano il parere dell’esperto: ciò che mostra la difficoltà della scuola di ieri e di oggi nel trasmettere un’adeguata educazione in fatto di lingua, ma anche il radicamento di certi temi (non sempre i più importanti) nell’immaginario collettivo. Il “sentimento linguistico” da cui muovono frequentemente i quesiti è spesso fondato su basi precarie, ispirate a un astratto logicismo e nutrito della convinzione di un’inarrestabile decadenza dell’italiano (che invece – lo ha ripetuto in tante occasioni Tullio De Mauro – proprio nel XX secolo è finalmente diventato codice condiviso dalla grande maggioranza dei cittadini , non più costretti a esprimersi solo nel dialetto natio). Sarebbe facile replicare, dunque, a molte considerazioni del genere, ed è certo doveroso farlo, sempre ispirandosi ai toni e alla civiltà di un Nencioni. Si può e si deve ricordare, ad esempio, che il parlato ha altre regole rispetto allo scritto e che la televisione, tanto spesso imputata di essere la principale responsabile del degrado, ha dato largo spazio al parlato reale ed è diventata piuttosto rispecchiamento che modello di lingua (e aggiungendo che ciò è stato possibile per l’appunto perché la lingua parlata oggi in Italia è molto più compatta e diffusa di quel che fosse quarant’anni fa). Oppure collocando nella storia fatti e tendenze che il parlante avverte operanti nell’immediatezza del presente in cui è immerso e precisando, poniamo, che il congiuntivo non è morto, né è recente l’assedio postogli dall’indicativo: dopo una completiva l’indicativo è spesso una semplice alternativa colloquiale, possibile fin dal XIV secolo, e per un’ipotesi irreale nel passato («Se lo sapevo, non partivo») l’uso è antico e ben acclimato persino in poesia. Ma una cosa è certa: tutte queste reazioni dei parlanti sono i sintomi di una salutare sensibilità – o ipersensibilità– nei confronti della lingua nazionale , di una “lealtà linguistica” che per l’italiano viene in genere considerata molto bassa rispetto a quel che accade altrove, nelle lingue (come il francese o lo spagnolo) e nei dialetti (come il veneto). E non si pensi che al tema siano sensibili solo persone anziane, che guardano all’evoluzione della lingua con atteggiamento nostalgico e comunque attribuendo a questi problemi un’attenzione non condivisa da fasce di popolazione più dinamiche. Navigando in Internet,
non è difficile imbattersi né in siti dedicati alla lingua, né, quel che più conta, in forum di discussione ai quali partecipa verosimilmente un pubblico giovane e disinvolto nel dominare le risorse della tecnologia elettronica.